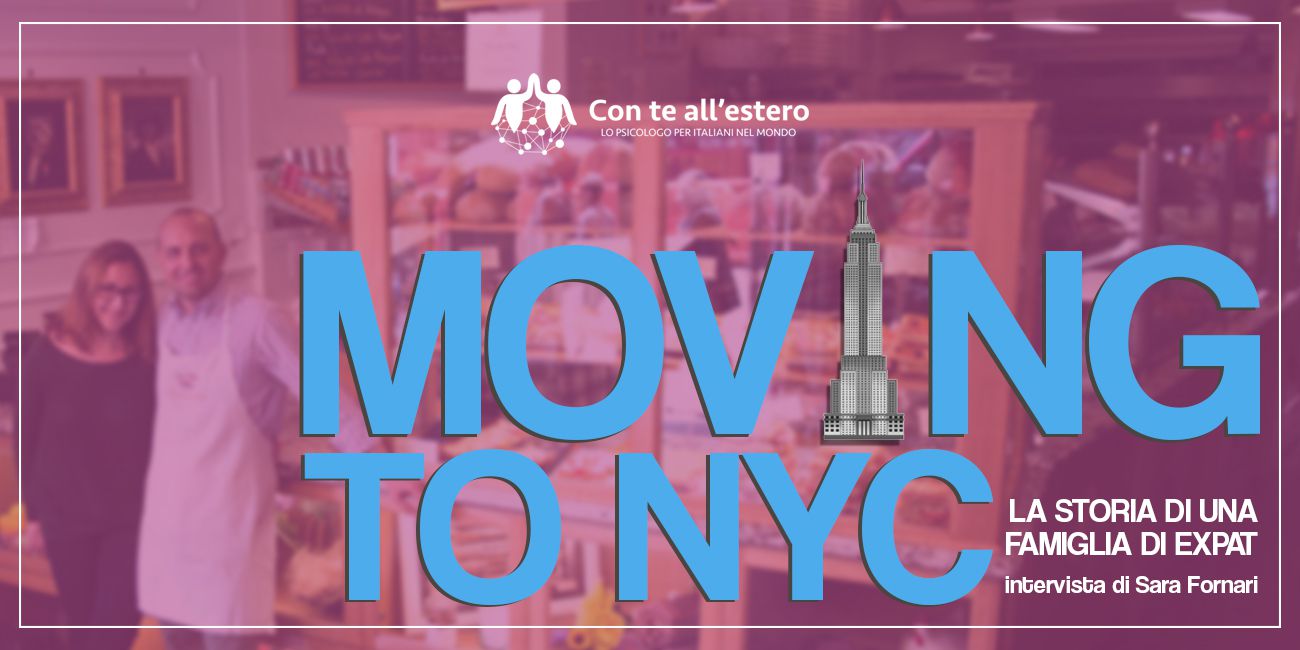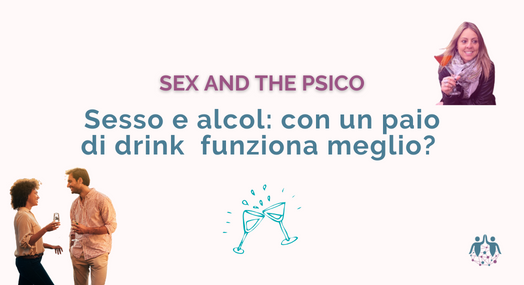Simone Bertini e Teresa Villi, pratesi doc, da dieci anni vivono e lavorano negli Stati Uniti: una coppia che ha deciso di mettersi in gioco, di rischiare per darsi una nuova possibilità, per provare a costruire un futuro diverso da quello più “scontato”, in qualche modo già scritto, che aveva in Italia e per offrire alla propria figlia opportunità diverse.
Sara Fornari li ha incontrati a New York e loro le hanno raccontato la propria esperienza da expat. Buona lettura!
![]()
Simone e Teresa, fino al 2009 conducevano una vita “ordinaria” in Italia. Poi, l’occasione per Simone di aprire un forno di specialità toscane a West Village – New York City, insieme ad un socio. Teresa, Psicologa e Psicoterapeuta, lo ha seguito un anno e mezzo più tardi con la loro bambina di circa 4 anni.
Oggi vivono a Jersey City, a due passi da Manhattan (anzi, a due fermate di Path…), dove Simone da alcuni anni ha aperto un’attività tutta sua: Prato Bakery, dal nome della loro amata città di origine. Questo angolo di Toscana negli Stati Uniti è una caffetteria italiana (potete trovare l’espresso, quello vero!) e americana, oltre che un forno. Simone ogni giorno sforna infatti cantucci di vari gusti (i biscotti tipici a Prato) e schiacciata, la gustosa focaccia toscana, da farcire con salumi e formaggi provenienti dall’Italia e tanti altri prodotti. Un paio di anni fa hanno aperto anche una filiale a Hoboken – New Jersey.
Teresa, che in Italia è specializzata in Psicoterapia, ha ottenuto negli Stati Uniti anche il diploma di Life Coach ed esercita nel suo studio nel quartiere di Soho a Manhattan, oltre che online. Inoltre, aiuta Simone ad organizzare eventi privati alla bakery e a gestire le spedizioni di cantucci in tutti gli Stati Uniti.
Gaia, la loro “bambina” ormai quasi adolescente, ha un delizioso accento newyorkese quando parla inglese e un perfetto accento toscano (pratese ndr) quando parla italiano. È un’eccellente aiutante alla bakery, dove fin da piccola ha sempre amato dare una mano, divertendosi soprattutto alla cassa.
Amanti degli animali, ora hanno anche un cane, Rocco, che li adora, e che hanno adottato dal canile. Teresa ama infatti il motto “adopt don’t shop”.
Rispondendo alle mie domande, mi hanno raccontato la loro esperienza americana da due diverse prospettive. Il punto di vista di Teresa è quello di una donna e di una professionista, che ha cambiato la propria vita per ricostruirne una nuova dall’altra parte del mondo, in parte reinventandosi, e considera quest’esperienza molto formativa e arricchente, anche se a tratti difficile; ma è anche il racconto di una mamma, che vede nell’esperienza della propria figlia anche le difficoltà di una ragazza “divisa tra due mondi”, quello delle tradizioni familiari e dei legami italiani, e quello del contesto in cui cresce, si forma, costruisce relazioni.
Simone ci offe invece lo sguardo dell’imprenditore, che si sofferma ad osservare il contesto socio-economico e lavorativo newyorkese e lo confronta con quello italiano, ma anche del padre di famiglia che sente la responsabilità della scelta di vita fatta ormai più di 10 anni fa e che continua a portare avanti con impegno, passione e dedizione.
Entrambi vedono questa esperienza via dall’Italia come una fase della loro vita e molto probabilmente prima o poi torneranno a vivere a Prato. Simone consiglia a tutti i giovani italiani di fare un’esperienza all’estero e a chi vive fuori di non rimpiangere l’Italia, finché si è via. Teresa lascia un messaggio agli expat, attuali o futuri, che è quello di non mollare nei momenti duri che inevitabilmente incontreranno, perché quella all’estero è un’esperienza di vita che vale davvero.
Di seguito un approfondito viaggio tra le parole dei due coraggiosi expat. Trovate infatti qui le due interviste, che corrispondono in maniera quasi del tutto fedele alle parole di Teresa, prima, e di Simone, poi.
TERESA
Quando vi siete trasferiti?
Mio marito è partito a giugno 2009, io e mia figlia lo abbiamo raggiunto a dicembre 2010.
Perché partire e perché proprio qui?
Volevamo cambiare qualcosa. Nostra figlia era appena nata quando Simone ha avuto l’idea. Volevamo darle l’occasione di crescere in un posto diverso dall’Italia, che però rimane sempre la nostra patria. Questa occasione si è presentata quando mio marito ha avuto la possibilità, con un socio, di venire a New York e aprire un forno di specialità toscane. Quando lui me lo ha proposto io stavo lavorando, andava tutto bene e mi sembrava una cosa fuori dal mondo. Parlandone però ho capito che era la cosa giusta da fare, perché tanto l’Italia non ce la toglie nessuno e potremo sempre tornare, con un bel bagaglio di esperienza in più e un’opportunità data a nostra figlia di crescere e andare a scuola qui.
Com’è stato all’inizio, con una bambina piccola?
Molto difficile ambientarsi alla cultura americana, anche a livello educativo è molto diverso. All’asilo in Italia, mia figlia era abituata a giocare, invece qui già l’ultimo anno è molto più strutturato, ti danno già le basi per leggere e contare, con una spinta alla competitività fin da piccoli e orientati ai risultati con obiettivi precisi. In Italia invece si intende l’educazione in maniera più “globale”, non solo scolastica e legata ai voti, ma alla crescita del bambino in tutti i sensi. Negli Stati Uniti ci sono test standardizzati fin dalle elementari, ogni anno, e chi non rientra in un certo livello viene fin da subito etichettato. E questo è uno specchio di come poi funziona la società americana.

Questa è una grande differenza. Ne hai trovate altre?
La mancanza di flessibilità, forse data proprio da questo tipo di educazione, molto settoriale. Per noi italiani è facile parlare e districarci in cose diverse, passando da un argomento all’altro o trovare soluzioni fuori dall’ordinario, a volte purtroppo anche in maniera non tanto corretta. Qui questo non c’è e mi sono dovuta adeguare. Da un certo punto di vista è anche corretto: tu stai in delle regole e sai che se sbagli, paghi.
Hai trovato delle differenze anche nelle relazioni, nel modo di crearle?
Sì, infatti la maggior parte dei nostri amici sono italiani. Di americani ne abbiamo proprio due o tre e sono quelli più vicini alla nostra cultura. Per esempio, con un americano per andare a cena fuori devi organizzare un mese e mezzo prima e tutto nei dettagli, scrivendoti mail. Noi italiani siamo abituati anche a dirci “vieni a cena da me stasera?” o “andiamo a mangiare una pizza domani?”. È molto più semplice. Quindi trovo più difficile fare amicizia con gli americani e più semplice con gli italiani, o comunque con gli europei.
Parlavi già inglese all’inizio?
Sì, mi piaceva e oltre ad averlo fatto a scuola, ero stata un periodo a studiarlo negli Stati Uniti.
Quanto pensi che questo ti abbia aiutata, soprattutto all’inizio?
Sicuramente mi ha aiutata moltissimo, a non sentirmi proprio spaesata. Perché, altrimenti, all’inizio possono essere difficili anche le più piccole cose.
Ci sono stati comunque degli scogli legati alla lingua?
(Sorride) Certamente sì, perché per gli americani non è tanto comprensibile l’umorismo italiano. A volte ti trovi in quelle situazioni imbarazzanti in cui vorresti fare una battuta, provi a farla in inglese – e già non ha lo stesso peso di quando la fai in Italia – e poi vedi una faccia interrogativa davanti a te ed è ancora peggio. Al di là della lingua, forse è proprio il concetto di umorismo che è diverso.
Quello che hai costruito è vicino, simile, a quello che ti aspettavi o è invece diverso?
È totalmente diverso (sorride). Io mi sento una persona totalmente diversa da quella che è partita dieci anni fa. Mi sento cambiata in meglio, perché in Italia ero molto chiusa in certi parametri: il lavoro, una definizione netta di quello che avrei fatto nella vita… E invece qui, avendo a che fare con tante cose difficili e con tante cose belle, mi sono resa conto che posso essere tutt’altro. Quindi è stata una grande esperienza.

Come gestisci l’appartenenza a due mondi? Perché c’è un’identità qui ora e anche un mondo là che ti appartiene sempre?
Io mi sento italianissima e mi sento qui solo per fare un’esperienza. Per ora. Poi non so se quando tornerò in Italia (perché ho sempre l’intenzione di farlo), avrò la sensazione di trovarmi al posto mio. Però ora io ho l’idea che qui sono di passaggio e invece il mio mondo è in Italia. Quello che è curioso è invece quello che dice mia figlia, perché a lei ogni tanto prende la malinconia e dice “voi avete creato un “blob” nella mia vita, perché io non mi sento né italiana né americana” e questo concetto di “blob” è interessante. Lei si sente a mezzo, io mi sento là e qui solo di passaggio.
Come se fosse più difficile per lei trovare il modo di integrare i due mondi?
Sì, perché io so a dove appartengo. Quando io ho lasciato avevo 36 anni, quindi ero già una donna fatta, anche se, come ho detto, dopo sono cambiata. Cosa che forse non avrei fatto se fossi rimasta in Italia: ho scoperto delle cose di me che non credevo di avere. È stata un’esperienza molto formativa.
Cosa ti piace di più qui e cosa di più in Italia?
Qui la facilità con cui si fanno le cose pratiche e burocratiche, come la patente o aprire un conto in banca… Mi piace molto la libertà che c’è qua, ma consideriamo che qui siamo nella “New York area”, quindi non è l’America. Qui c’è molta libertà e tolleranza, cosa che magari in Europa non in tutti i Paesi c’è e in Italia sicuramente no, perché la Chiesa incide ancora moltissimo. Invece qua vedo una grandissima libertà. Per dirti, quando è arrivato l’anno in cui tutti fanno la prima Comunione in Italia – qui ovviamente questa cosa non c’è – mia figlia sentiva i cugini e gli amici in Italia e si chiedeva cosa fosse. Qui mi sono sentita più libera da queste imposizioni che sono culturali nel nostro Paese. Qui non c’è l’imposizione. Qui basta che paghi le tasse, non fai del male a nessuno e sei libero di fare quello che vuoi. Ma veramente. La gente si inventa qualsiasi tipo di lavoro, che è una grande cosa, perché ti permette di applicarti in vari ambiti.
Anche provare a sperimentarsi in cose diverse, anche fuori dal tuo percorso…
Esatto. Qui non sei etichettato perché sei avvocato, per dire, e fai quello e basta. Qui c’è l’avvocato che va ad insegnare yoga e poi va a dipingere la sera e non gli viene data meno credibilità come avvocato. In Italia penserebbero che non è serio. C’è sempre questo pensiero, che comunque tu sei una cosa e devi fare quella.

Cosa ti piace di più dell’Italia invece?
Dell’Italia mi piace la gioia di vivere, cioè il godersi la vita. Qui invece i tempi sono molto stretti, devi lavorare molto e difficilmente c’è la distrazione mentale, il dire “vado a pranzo fuori e mi rilasso due ore”. Qui c’è tanta gente sola, tutti pensano a lavorare e basta, non c’è la stessa gioia di fare le cose. Dell’Italia mi manca questo, la possibilità di godersi la vita, la facilità con cui le persone se la godono. La mentalità proprio: potersi prendere degli spazi per sé senza dover sempre rincorrere il lavoro.
Pensi che questo sia particolarmente forte qui nell’area di NY o in generale negli Stati Uniti?
Qui è molto forte, ma in tutti gli Stati Uniti c’è la mentalità del lavorare e darsi da fare per ottenere le cose che vuoi. Per esempio, gli americani non sono d’accordo che la sanità sia pubblica. Mi sono trovata a parlare con degli americani di come, per me, sia inumano non averla e loro mi hanno detto “perché dovrei usare i miei soldi per pagare i “lazy ass” che non vogliono lavorare? Io lavoro e mi pago la mia assicurazione. Chi impedisce a un altro di lavorare e fare quello che faccio io e di guadagnarsi quello che vuole?”.
Cosa consiglieresti agli italiani che stanno per partire per l’estero in generale, non necessariamente negli Stati Uniti?
Di cogliere tutto quello che trovano come un’esperienza. E che è sempre utile ricordarsi da dove si viene. Un’altra cosa secondo me molto importante è non partire con la rabbia verso l’Italia, perché questo poi magari ti porta a non apprezzare a fondo quello che c’è, ma a farlo solo perché non ti piace quello che c’era in Italia. Se uno lascia l’Italia, va via perché è curioso, non è che deve scappare. Questo volevo dire. Vai fuori dall’Italia perché sei curioso di vedere altre realtà e altre culture. Lì poi ti arrabbi, perché ti accorgi di come può essere facile e veloce rispetto all’Italia avere delle cose. Però devi partire non perché sei arrabbiato, ma perché sei curioso di vedere altri posti e capire come funziona il mondo.
Teresa, un’ultima dritta per chi si è appena trasferito?
Ci saranno momenti molto difficili, però non ti abbattere, perché ne vale la pena!
SIMONE
All’inizio come è stato, per te che sei anche partito solo?
Difficile, è stato molto difficile. Prima di tutto perché avevo mia figlia piccola, quindi sentivo la sua mancanza, e quella di Teresa ovviamente ..è stata molto dura. Poi non conoscendo nessuno, non parlando nemmeno inglese, è stata ancora più dura. Più difficile ancora perché non sono andato a vivere a New York, ma per risparmiare sono andato a un’ora di macchina da Manhattan, nella landa desolata del New Jersey (sorride). Il primo inverno, con le nevicate, veniva un po’ di malinconia. Non è stato facile per queste cose e poi, a livello proprio pratico, è stata dura cercare l’avvocato, l’agente immobiliare, la location per aprire il negozio. Arrivi qui in questa mega città, grattacieli infiniti, un sacco di gente e devi capire come fare tutto, devi trovare i fornitori, per la farina, le uova, il prosciutto, ecc. Poi cercare l’avvocato per l’immigrazione, avviare le pratiche per accedere a un visto per stare qui, perché quando io ho aperto a settembre 2009 non avevo ancora il visto, quindi è stato un doppio rischio. Il negozio ha anche preso fuoco il giorno prima dell’apertura e io avevo sempre il visto turistico, quindi ogni 90 giorni dovevo tornare in Italia. Però sono rischi che devi prendere, perché ti giochi la vita. Io mi sono giocato anche un po’ di rapporti familiari, perché il mio babbo ha iniziato a parlarmi poco tempo fa. È stata dura, però con la forza del volersi mettere in gioco, la sfanghi.
E quello che hai ora è come te lo aspettavi?
Io ho sempre voluto fare questo da quando sono arrivato. Però prima avevo altri due soci, poi sono successe delle cose e il destino ha voluto che io prendessi la mia strada. Però è quello che volevo, perché facendo l’imprenditore ho sempre voluto lavorare per conto mio e ampliare la rete di vendita. Non è facile, perché New York è una centrifuga. Anche se vivo a Jersey City, però è sempre area metropolitana di NY e la gente che vive qui lavora tutta a Manhattan. Quindi qui sono radicati gli stessi ritmi e la città “ti macina”, perché non hai la certezza del domani. Non me l’ha ordinato il dottore di venire qua. È una sfida grossa. Ma a distanza di dieci anni devo dire che è anche logorante. Ora devo correre, perché a 45 anni non posso permettermi di sbagliare come se avessi 20 o 30 anni. Sento la stanchezza e la pressione. Anche perché ho la responsabilità di non essere solo, ma di avere una famiglia.
Come concili l’essere italiano con la tua appartenenza al mondo americano?
Ad un certo punto non sei né carne né pesce. Come capita a tanti emigranti. Quando me lo raccontavano, io non ci credevo e dicevo “sei stato 30 anni in Italia, come ti puoi scordare? Ma non è questione di scordare, è che poi subentrano l’abitudine e il ritmo di qui. Così quando sei qui ti manca l’Italia e quando sei là dopo un po’ non vedi l’ora di tornare a New York, perché ti manca questa energia. Qui se hai voglia di fare e un’idea valida – non improvvisare perché qui se sbagli la paghi doppia – ti danno i mezzi per partire e metterti alla prova subito. È immediato qui. Quindi ci sono tante cose molto positive a livello economico e lavorativo.

E a livello sociale?
Quando vieni qui dall’Italia è dura. Molto dura. Perché qui lavori e basta. Esci ogni tanto con gli amici, ma anche loro corrono e quando si va a cena si pensa già a quello che si deve fare la mattina dopo, per cui ti godi poco la cena e non stacchi mai.
Pensi che se tu lavorassi in Italia questo aspetto sarebbe diverso?
È dura anche lì. So cosa vuol dire, soprattutto lavorare in proprio. In Italia è triste perché non vedi futuro. Qui si lavora come muli però, se ti prefiggi un obiettivo, lo raggiungi. Sputando sangue, ma lo puoi raggiungere. In Italia ti prende la depressione, ma non perché lavori troppo, ma perché non vedi futuro o perché non c’è lavoro. In Italia tante famiglie non possono permettersi di comprare delle cose per i figli o di andare in vacanza. Anche qui succede, ma ti puoi rimettere in gioco, perché c’è tanto di quel lavoro. Se hai studiato per fare l’ingegnere e non trovi un posto per quello, puoi andare a fare lo spazzino, e qui a New York gli spazzini guadagnano un patrimonio. Vorrà dire che farai lo spazzino finché non trovi un posto da ingegnere, ma poi lo trovi. Se non è a 20, è a 30, 40, 50 o 60, ma un posto lo trovi qui. A 50 anni se perdi lavoro in Italia, chi ti prende? Qui sì.
Però non è facile arrivarci negli Stati Uniti?
Per i visti no. Però se vieni da investitore, con 100.000 dollari, mi pare che ora sia quella la cifra, puoi avere accesso al visto E2, rinnovabile ogni qualche anno. Ma prima di venire in America, io consiglio a tutti di uscire, perché in Italia un giovane non ci può stare, è sacrificato, è dissanguato.
Quindi consiglieresti di fare un’esperienza all’estero per poi tornare o di rimanere fuori dall’Italia?
A un giovane, che magari ha appena finito gli studi, direi di fare un’esperienza all’estero. Non dico per forza in America, che è lontana ed è anche un’altra mentalità. Però magari in Germania, in Francia o in Spagna. So che ora l’economia non è il massimo neanche in Spagna, però il punto è provare. Consiglierei di uscire per fare un’esperienza e poi magari tornare. Anche se un giovane che viene qui in America, difficilmente tornerà in Italia. Perché se vuole aprire un’attività per conto proprio e ha le credenziali giuste, l’accesso al credito è semplice. Come fa in Italia? È dura.

C’è anche chi vive fuori, però sente di non farcela più e vorrebbe rientrare in Italia. Cosa diresti a queste persone?
Di tenere duro e resistere, perché ora non è il momento di tornare in Italia. E difficilmente cambierà la situazione lì. Sono sempre stato ottimista di natura, ma per l’Italia purtroppo la vedo male. Anche nelle zone dove c’è più lavoro e si può vivere bene, hai sempre a che fare con la burocrazia, con i vari “mangia-mangia”, e ti vai a scontrare con delle realtà a cui non sei più abituato. È difficile, molto difficile. C’è chi non paga le tasse, chi non ha prospettive e chi non si sforza nemmeno di migliorarlo questo Paese. È triste, perché avremmo l’oro. Quando vivi all’estero te ne rendi conto della mentalità. Ma forse questo disagio sociale ci ha permesso di essere un po’ più scaltri, di saperci destreggiare in quel settore tra il bianco e il nero, il grigio, dove gli Americani non ci sanno stare. Poi vai all’estero e ti accorgi di quanto siamo autolesionisti noi italiani.
Se non ci fossero queste problematiche di cui parli, pensi che si vivrebbe meglio in Italia che altrove?
Sicuro. Garantito. Qui sono sempre nervosi e ansiosi, perché non sanno quello che succederà domani. Come si dice qui “you never know”. Le cose cambiano velocemente, domani ti può cambiare da così a così. Per chi lavora nelle grosse corporation, domani mattina può arrivare il supervisor e magari ti dice “ho trovato uno meglio” e tu prendi il pacchettino con le tue cose e vai via. Tu magari avevi firmato il mutuo per la casa e vieni licenziato, senza preavviso. Anche per me è lo stesso discorso. Anche se ho il negozio, anche per me può cambiare domattina. Qui sono degli automi: si svegliano la mattina, sanno quello che devono fare e vanno, per strada hanno lo sguardo assorto, anche in metropolitana ognuno pensa a se stesso. Però il carrozzone va, la ruota gira, bene o male, anche se ci sono dei problemi riescono a farla girare questa economia. In Italia no, è difficile.
Simone, quali sono invece le cose che ti piacciono dell’Italia?
Il mangiare e il bere. Gli amici. L’Italia è bella, c’è poco da fare, ma devi andare lì non per lavorare. Si sta bene se si hanno i soldi e non si deve lavorare.

Teresa pensa sia meglio non andarsene dall’Italia arrabbiati, nonostante i suoi difetti. Tu cosa ne pensi?
Per me è il contrario. Se uno va via deve partire incazzato nero con l’Italia. Hai mai visto un americano che va via? Sì, lo fa per un periodo, lo fa per studiare in Italia, ma poi tutti tornano. Meglio partire arrabbiati, perché se le cose funzionassero seriamente, molti non verrebbero via dall’Italia. Se un giovane presenta un progetto al Comune di una città in Italia gli ridono dietro, mentre se uno qui al Comune a Jersey City si presenta con una nuova idea, lo finanziano per aiutarlo a promuoverla. L’accesso al credito è per la grossa azienda come per i piccoli. Io sono partito arrabbiato perché in Italia è più facile fare il disonesto che l’onesto. I miei valori sono quelli di essere una persona onesta. Voglio lo stesso per mia figlia, non che cresca in un Paese dove trovi lavoro se sei l’amico dell’amico o ti devi togliere la dignità davanti ad un direttore di banca per avere il mutuo della casa, con il babbo che mette la firma a garanzia.
Simone, quindi cosa consiglieresti a chi sta per partire?
Di viverlo come un’opportunità, secondo me però con una scadenza. E intanto di non pensare all’Italia, di pensarci solo per tornare in vacanza.
![]()
Ringrazio Simone e Teresa per questo racconto. Li ringrazio per avermi accolta nella loro casa, avermi parlato della loro esperienza e dato la possibilità di condividerla con chi ci segue.
Sara Fornari
Psicologa e Psicoterapeuta