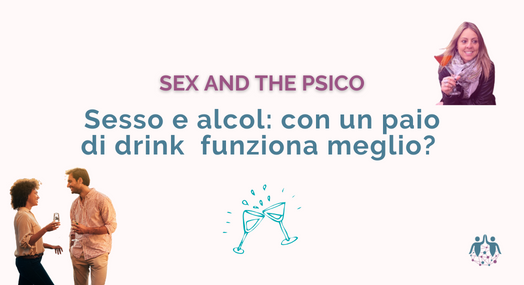“Che cosa aveva riportato dal suo viaggio? Niente, si potrebbe dire! Nient’altro che una giovane signora che, per quanto inverosimile ciò possa sembrare, lo rese il più felice degli uomini! In verità, non si farebbe, anche per molto meno di questo, il giro del mondo?”.
Ve lo ricordate il celebre romanzo “il giro del mondo in ottanta giorni” di Jules Verne dove Phileas Fogg, un aristocratico inglese, nel 1873, gira tutto il mondo tra rocambolesche avventure e forti emozioni senza che gli venga mai chiesto di presentare un documento di riconoscimento. Oggi, ahimè, non è più così!
È vero, ci muoviamo molto di più, viaggiare è diventato facile e veloce ma non per tutti come ci informa il Passaport Index dipende infatti da dove siamo nati: se dalla parte giusta o dalla parte sbagliata del mondo.
E tutto questo è una questione di caso, di fortuna, non di merito.
Un cittadino italiano come la maggior parte dei suoi colleghi europei nonché di quelli statunitensi e giapponesi può andare in 162 paesi del mondo senza che gli venga chiesto il visto, è dunque un privilegiato che può entrare liberamente quasi ovunque. Un afgano invece può entrare solo in 30 paesi, un iracheno in 33, un pakistano in 34 e così via e di solito non sono i paesi dove desidererebbero andare.
Questa differenza, come è facile immaginare, non riguarda soltanto la possibilità di viaggiare per turismo ed ha enormi implicazioni sulla libertà di circolazione e sulle disuguaglianze che la caratterizzano.
C’è da stupirsi se, non potendo arrivare legalmente, molti ci provino nell’unico modo possibile, ossia illegalmente? Chi scappa da una guerra, da una persecuzione etnica o religiosa fuggirebbe in ogni modo possibile pur di salvarsi. Ma facciamo un passo indietro.
Per avvicinarsi ad un argomento tanto complesso quanto delicato come il fenomeno delle migrazioni occorre liberarsi da tutte quelle scorciatoie mentali, i pregiudizi, i retaggi, gli stereotipi nei quali tutti noi spesso cadiamo.
Che cosa significa partire forzatamente, scappare dalla propria terra natale, vivere in un paese colpito da guerre, persecuzioni, coercizioni?
Che cosa può accadere durante quelle attraversate chilometriche, quei viaggi della speranza, che cosa possono vedere quegli occhi?
Cosa provano tutte le donne, i bambini, gli uomini di cui tanto sentiamo parlare ma di cui così poco conosciamo?
Cerchiamo di comprenderlo attraverso le loro parole, le loro storie. Di seguito alcune testimonianze raccolte in un docufilm dal titolo “Storie di migrantes”.
Abraham, Corno D’Africa:
“…ogni volta che penso a quello che è successo in Libia, sto male, divento triste. Da quando sono arrivato in Italia ho iniziato ad andare in chiesa tutti i giorni perché mi aiuta a dimenticare quello che ho passato…in carcere venivamo picchiati ogni giorno, a volte ci legavano le mani, ci portavano fuori sul deserto e ci lasciavano al sole, tanti bambini sono morti perché non riuscivano a sopravvivere a quel caldo..
I più forti e robusti venivano portati in un altro posto per essere torturati…”.
Kelvin, Nigeria:
“….Non è stato facile partire.. le prime notti che ero in mare dentro di me cercavo di essere forte per poter sopravvivere… la destinazione era ancora lontana, non c’erano alternative: se dovevo sopravvivere sarei sopravvissuto, se dovevo morire sarei morto..
Eravamo 97 persone sulla barca.. c’erano persone che stavano soffrendo, ci sono state delle lotte durante l’attraversata per fortuna sono riuscito a cavarmela, penso che Dio mi abbia dato una mano.
Se dovevo sopravvivere sarei sopravvissuto se dovevo morire sarei morto.
Fortunatamente nessuno è morto durante il viaggio, siamo rimasti in mare per nove ore infine siamo stati soccorsi..”
Alieu, Gambia:
“…La traversata in mare non è stata per niente facile, nella barca in cui eravamo c’era molta scarsità di cibo e acqua… quando ci hanno soccorso eravamo disperati, purtroppo alcune persone non ce l’hanno fatta, due persone sono morte…quando sei in mare e guardi di fronte a te l’unica cosa che vedi è l’acqua e ti senti come imprigionato, ti rendi conto di quello che può accadere, quando guardi vicino a te e vedi morire tante persone non hai più la certezza di sopravvivere….”
Mirta, Bosnia:
“Mirta ha sette anni viene dalla Bosnia. Vive con i genitori e una sorellina piccola in una città dell’Italia settentrionale. Papà lavora tutto il giorno e riesce a guadagnare bene. Ma la mamma, che prima della fuga ha subito violenza nel paese di origine è in condizioni molto gravi: è depressa, soffre di qualche disturbo fisico, ha dolori in molte parti del corpo e non riesce ad occuparsi della casa e delle bambine. Così Mirta ogni giorno, quando torna a casa prepara i pasti e si prende cura della casa e della sorellina. Ha sempre un aspetto preoccupato e il suo rendimento scolastico è basso”. (Tratto da Il Dialogo Transculturale di Marco Mazzetti).
Dare un nome a volti indistinti è necessario per comprendere, rendere leggibili percorsi che apparentemente non lo sono aiuta ad allargare il nostro sguardo, capire i bisogni e le motivazioni che spingono le persone a partire è, a mio avviso, anche un dovere morale.
Abraham, Kelvin, Alieu, Mirta sono coloro che chiamiamo richiedenti asilo, rifugiati politici, immigrati, clandestini, profughi, minori non accompagnati. Termini che portano con sé già tutto il peso, la distanza, lo stigma, la solitudine di chi purtroppo molto spesso ha maturato la consapevolezza che su di sé si possa fare qualsiasi cosa.
Coloro disposti a tutto pur di salvarsi, che preferiscono rincorrere una speranza anche in condizioni di estrema difficoltà, subendo violenze, maltrattamenti, periodi di detenzione, torture pur di provare a farcela, pur di avere un’occasione in più.
E quando finalmente riescono ad arrivare in quel tanto sognato, immaginato “altrove”, catapultati in una realtà totalmente diversa, dove si parla un’altra lingua, il più delle volte soli, portatori di elementi culturali che hanno una loro logica ma che spesso non sono compresi, non ci sarà difficile immaginare come il senso di angoscia, di spaesamento, la solitudine possano farsi spazio nella mente e nel cuore di queste persone.
Il sociologo franco algerino Abdelmalek Sayad scrive: “la presenza dell’immigrato è sempre una presenza segnata dall’incompletezza, è colpevole in sé stessa. È una presenza fuori posto [déplacée] in tutti i sensi del termine”.
Sayad descrive molto bene come il migrante possa sentirsi spesso “fuori luogo”, nello sforzo continuo di mantenere i rapporti tra “il qui” e “il là” cercando di ricostruire uno spazio dove il passato e il presente possano incontrarsi ed amalgamarsi.
Non è facile mantenere i fili della propria storia, trovare una strada individuale per conservare il senso positivo delle proprie origini e della propria cultura che è fonte di sapere, di competenze e di significati ancora validi e utili ma inseriti in un contesto profondamente diverso.
La migrazione deve essere considerata un’esperienza di rottura e fragilizzazione per tutti i migranti e come tale dovrebbe essere gestita mettendo in campo tutte le risorse possibili.
Questi sono alcuni spunti di riflessione su un tema molto complesso che non può essere affrontato solo da un punto di vista economico o demografico.
Farsi delle domande, approfondire l’argomento con uno sguardo nuovo vuol dire considerare tutto quello che la migrazione implica in termini di accoglienza, integrazione, lavoro, accettazione, partendo da un assunto che può sembrare banale ma non lo è affatto: “tutti gli esseri umani sono uguali e hanno pari dignità”.
Pamela Alunni
Psicologa e Psicoterapeuta